|
Le eruzioni |
|
|
Eruzioni antiche |
Questa breve
descrizione di alcune eruzioni che hanno colpito la città di Catania,
vuole solamente fornire uno spunto di riflessione che possa aiutarci ad
avere qualche dubbio circa le molteplici affermazioni, spesso destituite
di fondamento scientifico, fatte ai giorni nostri da tanti sedicenti
scienziati della Terra a proposito dell’Etna, delle sue eruzioni e così
via discorrendo….
 La
prima eruzione documentata dell’Etna (Diodoro siculo) avvenne ai
tempi dei Sicani nel 1470 a.C. (vedi cronologia della città di
Catania su questo stesso sito). Il territorio su cui sorge l’odierna
città di Catania è stato invaso da numerose colate laviche (datate e
non) provenienti da eruzioni laterali ed eccentriche che lo hanno
radicalmente trasformato. La linea di costa era molto più arretrata e
frastagliata dell’attuale ed inoltre la superficie su cui si estendeva
la città era minore; le lave infatti hanno contribuito a creare nuove
terre laddove c’era il mare. La
prima eruzione documentata dell’Etna (Diodoro siculo) avvenne ai
tempi dei Sicani nel 1470 a.C. (vedi cronologia della città di
Catania su questo stesso sito). Il territorio su cui sorge l’odierna
città di Catania è stato invaso da numerose colate laviche (datate e
non) provenienti da eruzioni laterali ed eccentriche che lo hanno
radicalmente trasformato. La linea di costa era molto più arretrata e
frastagliata dell’attuale ed inoltre la superficie su cui si estendeva
la città era minore; le lave infatti hanno contribuito a creare nuove
terre laddove c’era il mare.
Descritta da Tucidide e Strabone, la catastrofica eruzione avvenuta
nel 693 a.C., ha attraversato la storia come la lava dei fratelli
pii (Anfinomo e Anapìa), leggenda ricordata in uno dei quattro lampioni
di piazza Università. Quest’eruzione determinò la distruzione
dell’antica Katàne. Le lave, provenienti da fratture eruttive poste a
nord-est di Mascalucia (area attualmente occupata dall’apparato eruttivo
di Mompilieri, cono secondario posto a Sud-ovest di Nicolosi),
procedendo in direzione Sud, giunsero sino in città: circondarono la
collinetta di Cifali, formarono le alture di Catania (Bastione
degli infetti, S. Marta, Monastero dei Benedettini, Fortino vecchio,
Cappuccini, S. Agata al carcere, via Crociferi, Gesuiti, Terme
dell’indirizzo) e contribuirono alla creazione del Lago di Nìcito;
splendido specchio d’acqua; quest’ultimo fu completamente distrutto
durante l’eruzione del 1669 (descritta a parte)
Diodoro
siculo ci ha narrato dell’eruzione del 396 a.C. avvenuta al tempo
della guerra tra Dionisio ed i Cartaginesi. Le lave prodotte in quell’anno
impedirono ad Imilcone e alle sue truppe cartaginesi di arrivare a
Catania attraverso le spiagge completamente ricoperte da lave ancora
calde, costringendolo a girare intorno al monte.
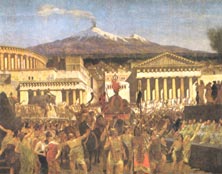 Le cronache cristiane, (nel finire dell’impero di Trajano Decio), hanno
lasciato scritto che: “… l’anno successivo alla morte della nobile
vergine cristiana Agata, martirizzata a Catania per ordine di
Quinziano pretore di sicilia…” giorno 1 febbraio del 252 d.C ebbe
iniziò una grande eruzione che si concluse il 5 febbraio dello stesso
anno. L’eruzione, prese origine da fratture eruttive poste alla base di
Monte Peloso in località grotta lunga a Nord-est di Nicolosi e secondo
tali cronache, le lave penetrate attraverso le colline di cibali si
portarono verso la parte nord della città per arrestarsi al Borgo; altre
fonti attribuiscono la formazione della scogliera conosciuta come
Larmisi nei pressi dell’odierna Piazza Europa. Le cronache cristiane, (nel finire dell’impero di Trajano Decio), hanno
lasciato scritto che: “… l’anno successivo alla morte della nobile
vergine cristiana Agata, martirizzata a Catania per ordine di
Quinziano pretore di sicilia…” giorno 1 febbraio del 252 d.C ebbe
iniziò una grande eruzione che si concluse il 5 febbraio dello stesso
anno. L’eruzione, prese origine da fratture eruttive poste alla base di
Monte Peloso in località grotta lunga a Nord-est di Nicolosi e secondo
tali cronache, le lave penetrate attraverso le colline di cibali si
portarono verso la parte nord della città per arrestarsi al Borgo; altre
fonti attribuiscono la formazione della scogliera conosciuta come
Larmisi nei pressi dell’odierna Piazza Europa.
L’eruzione parossistica del 122 a.C. produsse un’enorme quantità
di materiale piroclastico (sabbie,
scorie e ceneri vulcaniche) che, a causa dell’enorme peso esercitato
sopra i tetti, li fece crollare, lasciando migliaia di catanesi senza
abitazione. L’eruzione determinò una vera e propria catastrofe
(la distruzione dei campi coltivati infatti, determinò morti per fame).
Per questo motivo, il Senato romano esentò per dieci anni i catanesi dal
pagamento dei tributi onde rifarsi dalle perdite cagionate da quella
terribile eruzione. Questo evento eruttivo, determinò l’enorme
cratere del Piano su cui negli anni a seguire si sarebbe impostato il
cono del cratere centrale. Strabone, cento anni più tardi (VI, 2,
3-8) descrive con esattezza le dimensioni (Lunghezza, larghezza,
circonferenza e profondità dell’enorme caldera di collasso).
Nel 776 il mago Eliodoro (da cui il siciliano
Filodoro-Liotru nome con cui i catanesi identificano l’elefante di
pietra lavica sormontato da un obelisco egizio di Sienite (varietà di
roccia magmatica intrusiva o plutonica simile composizionalmente al
granito, posto al centro di piazza Duomo), si propose, naturalmente
invano di arrestare l’eruzione mediante una statua miracolosa.
E’ degna di speciale menzione l’eruzione iniziata a febbraio del 1169
e che devastò i campi dei catanesi e diede impulso ad una corrente di
lava che arrivò al mare presso il castello di Aci . Quest’eruzione fu
accompagnata da uno dei terremoti più funesti (4/2/1169)
(morirono oltre 15 mila persone) e fu completamente rasa al suolo la
città di Catania.
Simone da Lentini ci ha descritto l’eruzione del 5 agosto 1381
che produsse le cosiddette lave del crocifisso originatesi sotto
Tremestieri etneo (Monti Arsi e frattura eruttiva nota come fossa del
“cavòlo”). La lava corse tra Sant’Agata Li Battiati e Gravina e
poi ancora tra il Fasano e Leucatia e quindi a Catania lungo
l’area dove attualmente si sviluppa la circonvallazione,
distruggendo lungo il suo cammino tutti gli oliveti e arrivando in mare
tra il Gaito ed il Rotolo; quest’ultimo generato dalle lave del 426-425
d.C.- colmando quell’insenatura conosciuta come il porto di Ulisse.
Occorre dire che alcune di queste eruzioni alla luce dei metodi di
datazione basati sull’archeomagnetismo (J.C.Tanguy et al., 2003
“Archeomagnetic dating of Mediterranean volcanics of the last 2100 years:
validity and limits”) risultano essere occorse in epoche antecedenti
o susseguenti a quanto riferito nelle cronache desumibili dagli scritti
storici. Secondo questo lavoro, le lave del 1381 d.C. sarebbero
ascrivibili ad eventi eruttivi occorsi almeno mille anni prima; le lave
del 425 d.C. “Rotolo” risalirebbero al almeno 350 anni prima se non
addirittura ad epoca preistorica e le lave del 122 d.C. sono da imputare
ad eventi sicuramente preistorici.
|