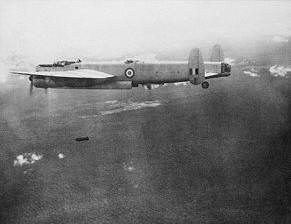|
L'ultimo bombardamento
E’ facile, direi umano, durante le annuali ricorrenze, natalizie e
pasquali, riandare con la mente al passato, specie quando si va più
innanzi con gli anni. Ricordiamo volti familiari da gran tempo
scomparsi, piccoli eventi legati ad una Messa di mezzanotte o ad un
tripudio di festose campane, doni fatti o ricevuti, un uovo di Pasqua
particolare per la sua sorpresa o un Natale riccamente imbandito.
Ma, fra tanti ricordi, per me le feste natalizie sono legate a qualcosa
di triste, anzi tragico o tragi-comico se volete ( se avrete la pazienza
di andare avanti); è come se proprio di quell’anno non potessi
liberarmi: la fine del ’43 e l’inizio del ’44.
 Già
questa data è indicativa, il penultimo Natale di guerra con i suoi lutti
e dolori, stragi e bombardamenti. Ma, in fondo per noi siciliani la
guerra era già finita, in agosto le truppe anglo-americane avevano
completato l’occupazione dell’Isola e bene o male si tornava a vivere e
a sperare che almeno per noi fossero finiti le angosce dei bombardamenti
e il terrore delle rappresaglie tedesche che già avevamo sperimentato,
anche se ancora da alleati. Ma, a parte questo, il resto era di uno
squallore desolante: macerie dappertutto, fame e miseria, in molte zone
della città mancavano acqua e luce, non si avevano notizie di parenti e
familiari rimasti dall’altra parte. Riuscire a fare almeno un pasto
al giorno era una impresa ardua e così pure procurarsi carbone o
medicinali indispensabili. Ma si ricominciava a vivere; come dopo
un diluvio, poco a poco, la vita riprendeva, si reagiva, si era scampati
alla guerra, bisognava farcela. Si viveva di espedienti, ci si
arrangiava col mercato nero, molte famiglie sopravvissero vendendo tutto
quello che avevano di prezioso o comunque che si poteva vendere: prima i
gioielli di famiglia, poi il corredo gelosamente custodito fino ad
allora nelle casse foderate di raso trapunto, poi i mobili, le pellicce,
i servizi di bicchieri e di piatti e antichi doni di nozze anch’essi
gelosamente custoditi, infine anche coperte e materassi di lana. Già
questa data è indicativa, il penultimo Natale di guerra con i suoi lutti
e dolori, stragi e bombardamenti. Ma, in fondo per noi siciliani la
guerra era già finita, in agosto le truppe anglo-americane avevano
completato l’occupazione dell’Isola e bene o male si tornava a vivere e
a sperare che almeno per noi fossero finiti le angosce dei bombardamenti
e il terrore delle rappresaglie tedesche che già avevamo sperimentato,
anche se ancora da alleati. Ma, a parte questo, il resto era di uno
squallore desolante: macerie dappertutto, fame e miseria, in molte zone
della città mancavano acqua e luce, non si avevano notizie di parenti e
familiari rimasti dall’altra parte. Riuscire a fare almeno un pasto
al giorno era una impresa ardua e così pure procurarsi carbone o
medicinali indispensabili. Ma si ricominciava a vivere; come dopo
un diluvio, poco a poco, la vita riprendeva, si reagiva, si era scampati
alla guerra, bisognava farcela. Si viveva di espedienti, ci si
arrangiava col mercato nero, molte famiglie sopravvissero vendendo tutto
quello che avevano di prezioso o comunque che si poteva vendere: prima i
gioielli di famiglia, poi il corredo gelosamente custodito fino ad
allora nelle casse foderate di raso trapunto, poi i mobili, le pellicce,
i servizi di bicchieri e di piatti e antichi doni di nozze anch’essi
gelosamente custoditi, infine anche coperte e materassi di lana.
Anche mia madre dovette arrangiarsi per sfamare tre
figlie ed una nipote di pochi anni; all’alba si metteva in fila per
prendere un po' di latte, poi correva dove si diceva che avessero
macellato un cavallo e vendeva mobili della casa e faceva piccoli
lavoretti di rammendo alle truppe alleate che avevano requisito il
palazzo di fronte. I militari ricambiavano con forme di pane bianco come
da anni non avevamo più visto, con carne in scatola, la famosa
“corned-beef” e marmellate e cioccolata il cui sapore avevamo
dimenticato e mia nipote di appena tre anni non aveva mai conosciuto.
Nessuna notizia di mio padre, militare in Grecia e di conseguenza
nessuna rimessa di denaro. La situazione era veramente grave ma mia
madre non si perdeva di coraggio e ogni giorno riusciva miracolosamente
a dare da mangiare a pranzo e a cena. Pranzi e cene a base di patate,
carote, peperoni e melanzane, legumi talvolta qualche uovo, carne e
burro quando ce li davano gli inglesi e pasta e pane, pane e pasta
sempre pasta e pane.
Si avvicinava Natale, un Natale diverso, un Natale pieno di promesse pur
nel buio del momento; era il primo Natale da liberi, era caduto il
fascismo e per noi era finita la guerra anche se erano svanite le
speranze di una fine generale di essa; speranze che si erano accese e
subito spente all’annunzio dell’armistizio. “La guerra continua”. Era
stata una doccia gelata ma per i siciliani comunque era veramente finita
la guerra e bisognava comunque festeggiare il Natale.
Per giorni e giorni parlammo del cenone o meglio del cenino, giacchè non
si poteva pensare a grandi cose ma almeno qualcosa che non fosse la
solita pasta e patate o pasta con i broccoli. Di carne o pesce manco a
pensarci, cacciagione era pura utopia solo il pensiero e allora?
“Faremo le pizze alla catanese!” Decise mia madre che non si
perdeva mai d’animo e con questa decisione che ci faceva venire già
l’acquolina in bocca, si mise a caccia di farina, dopo avere venduto
l’anello di rubini, ultimo di una serie che aveva già preso la via
dell’esilio. E dopo la farina, si procurò della “tuma” e delle acciughe
e aspettammo la sera di Natale; pregustavamo già il sapore delle pizze
che avevamo quasi dimenticato. Di pomeriggio, mia madre cominciò ad
impastare ed eravamo tutte intorno a lei a vederla di nuovo come un
tempo armeggiare con la farina, l’acqua, il matterello e poi stirare la
pasta, modellare le forme, riempirle con il formaggio, le acciughe, il
pepe, chiuderle, aspettare che lievitassero. Non sarebbero state certo
le gustose pizze d’anteguerra, poiché, non riuscendo a trovare farina di
frumento, mia madre si era dovuta accontentare di farina di ceci. Ma
sempre farina era.
I ngannammo
il tempo dell’attesa giocando a tombola con dei pezzetti di carta ( i
legumi erano una merce troppo preziosa) ma alle otto non resistevamo più
e ci trasferimmo di nuovo in cucina per riempirci gli occhi prima dello
stomaco delle croccanti pizze; c’era anche Bobby, il bastardino un po’
vecchiotto accucciato fra noi che stavamo in piedi, sperando che qualche
bocconcino cadesse anche per lui. Poverino! Anch’esso aveva sofferto la
fame nei primi tempi della guerra, poi si era fatto furbo e fra gli
accampamenti tedeschi prima e quelli alleati dopo non aveva certo
sentito i morsi della fame come noi. Comunque quella sera era là ad
aspettare e la sua attesa fu premiata perché un pezzetto di farina
fritta si era staccata dal resto e mia madre gli e la gettò. ngannammo
il tempo dell’attesa giocando a tombola con dei pezzetti di carta ( i
legumi erano una merce troppo preziosa) ma alle otto non resistevamo più
e ci trasferimmo di nuovo in cucina per riempirci gli occhi prima dello
stomaco delle croccanti pizze; c’era anche Bobby, il bastardino un po’
vecchiotto accucciato fra noi che stavamo in piedi, sperando che qualche
bocconcino cadesse anche per lui. Poverino! Anch’esso aveva sofferto la
fame nei primi tempi della guerra, poi si era fatto furbo e fra gli
accampamenti tedeschi prima e quelli alleati dopo non aveva certo
sentito i morsi della fame come noi. Comunque quella sera era là ad
aspettare e la sua attesa fu premiata perché un pezzetto di farina
fritta si era staccata dal resto e mia madre gli e la gettò.
Quale fu il nostro stupore nel vedere Bobby dapprima annusare con
sospetto il boccone poi decisamente rifiutarlo e girarsi disgustato
dall’altro lato. Ci guardammo in faccia, perplessi: Bobby rifiutare
qualcosa! Inaudito!
Un atroce sospetto si fece strada in noi: che non fosse farina di ceci?
“Assaggiamo questa” Disse mia madre con voce tremante. Prese una pizza
pronta, la divise in parti uguali, ce ne porse i pezzetti, li portammo
alla bocca con mano esitante e subito li sputammo per terra: era
farina di mandorle amare!
Dio, Che atroce disinganno! Ci vennero le lacrime agli occhi per la
delusione, la rabbia, la fame. Ma non c’era niente da fare. Cenammo con
del pane raffermo e la tuma che riuscimmo a recuperare estraendola dalle
pizze. Fu questo il mio primo cenone da “liberata”.
Ma ciò che veramente ha reso indimenticabile quelle “feste”, fu proprio
ciò che accadde l’ultima notte dell’anno e per qualcuno fu purtroppo
l’ultima in assoluto.
Mia madre non poteva rassegnarsi all’idea di essersi fatta ingannare e
ne fece una questione di puntiglio di preparare le pizze con tutti i
crismi; ancora sentivamo in bocca il sognato sapore delle pizze
trasformarsi in tossico; così si mise alla ricerca di farina, vera
farina di frumento e ancora una volta ripetemmo il rito di assistere
alle varie fasi: guardare mia madre impastare, aspettare che
lievitassero, giocare a tombola ( con la testa al prossimo festino ) e
scherzavamo fra noi, quasi a dominare il nervosismo e l’intimo timore di
un’altra delusione.
Comunque all’orario solito passammo in cucina, mia madre aveva già
acceso il carbone, mise la padella di ferro con la sugna; rivedo ancora
oggi la scena. Sembravamo come i pastorelli del presepe: io appoggiata
con le spalle al muro e le braccia sul manico di scopa, mia sorella Elda
con la figlia in braccio stava di fronte a me e l’altra mia sorella Ada
era appoggiata alla scaletta di legno che portava in soffitta; Bobby,
come al solito accucciato al centro. Gli occhi di tutte erano fissi
sulla padella da dove mamma toglieva gocciolanti le pizze, dorate e
fragranti. Stava per finire di friggere le ultime due pizze quando
sentimmo da lontano un rombo di aereo avvicinarsi ma non vi facemmo
caso. Ormai la guerra era finita, che potevamo temere?
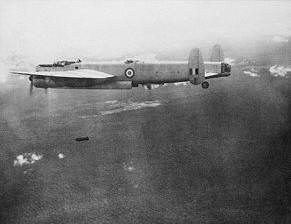
E invece in un attimo avvenne il finimondo. Prima la picchiata
dell’aereo, poi un sibilo lancinante, un fragore infernale vicinissimo,
la casa sembrò sobbalzare, poi schiantarsi, vetri vennero giù, fumo,
polvere,puzza di bruciato, poi silenzio. Un silenzio terrificante,
mostruoso. Come di morte. Ci guardammo increduli di essere ancora vivi.
Poi non si capì più nulla. Grida, Urla disperati, Fuggi-fuggi per la
strada. Eravamo come paralizzati. Eppure mia madre ebbe il sangue
freddo di scolare le ultime pizze. Dopo, solo dopo, corse al
balcone, dopo avere spento le luci e ci affacciammo tutte al balcone: a
poche decine di metri un palazzo sventrato bruciava mentre urla disumane
invocavano soccorso. Dal palazzo di fronte, occupato dai militari
scozzesi, giunsero subito barelle, cinque morti, altri feriti. Tornammo
tristemente dentro e mangiammo le nostre pizze che ci seppero più amare
di quelle di Natale.
La verità su quel bombardamento non si poté mai sapere. Chi aveva
sganciato quella bomba? Si disse che erano stati aerei tedeschi
accodatisi ad aerei americani ma i tedeschi non arrivavano più a quelle
distanze già da parecchi mesi; si disse pure e fu la versione più
accreditata, che era stato un aereo americano con pilota ubriaco a bordo
che voleva festeggiare il nuovo anno e pare che anche l’aereo fosse
precipitato in mare. Forse un’avarìa? Chissà.
Insomma quei poveri morti non hanno mai saputo perché
sono morti e i catanesi non hanno mai saputo chi sia stato l’autore
dell’ultimo bombardamento: un Tedesco o un Americano?
|
 Già
questa data è indicativa, il penultimo Natale di guerra con i suoi lutti
e dolori, stragi e bombardamenti. Ma, in fondo per noi siciliani la
guerra era già finita, in agosto le truppe anglo-americane avevano
completato l’occupazione dell’Isola e bene o male si tornava a vivere e
a sperare che almeno per noi fossero finiti le angosce dei bombardamenti
e il terrore delle rappresaglie tedesche che già avevamo sperimentato,
anche se ancora da alleati. Ma, a parte questo, il resto era di uno
squallore desolante: macerie dappertutto, fame e miseria, in molte zone
della città mancavano acqua e luce, non si avevano notizie di parenti e
familiari rimasti dall’altra parte. Riuscire a fare almeno un pasto
al giorno era una impresa ardua e così pure procurarsi carbone o
medicinali indispensabili. Ma si ricominciava a vivere; come dopo
un diluvio, poco a poco, la vita riprendeva, si reagiva, si era scampati
alla guerra, bisognava farcela. Si viveva di espedienti, ci si
arrangiava col mercato nero, molte famiglie sopravvissero vendendo tutto
quello che avevano di prezioso o comunque che si poteva vendere: prima i
gioielli di famiglia, poi il corredo gelosamente custodito fino ad
allora nelle casse foderate di raso trapunto, poi i mobili, le pellicce,
i servizi di bicchieri e di piatti e antichi doni di nozze anch’essi
gelosamente custoditi, infine anche coperte e materassi di lana.
Già
questa data è indicativa, il penultimo Natale di guerra con i suoi lutti
e dolori, stragi e bombardamenti. Ma, in fondo per noi siciliani la
guerra era già finita, in agosto le truppe anglo-americane avevano
completato l’occupazione dell’Isola e bene o male si tornava a vivere e
a sperare che almeno per noi fossero finiti le angosce dei bombardamenti
e il terrore delle rappresaglie tedesche che già avevamo sperimentato,
anche se ancora da alleati. Ma, a parte questo, il resto era di uno
squallore desolante: macerie dappertutto, fame e miseria, in molte zone
della città mancavano acqua e luce, non si avevano notizie di parenti e
familiari rimasti dall’altra parte. Riuscire a fare almeno un pasto
al giorno era una impresa ardua e così pure procurarsi carbone o
medicinali indispensabili. Ma si ricominciava a vivere; come dopo
un diluvio, poco a poco, la vita riprendeva, si reagiva, si era scampati
alla guerra, bisognava farcela. Si viveva di espedienti, ci si
arrangiava col mercato nero, molte famiglie sopravvissero vendendo tutto
quello che avevano di prezioso o comunque che si poteva vendere: prima i
gioielli di famiglia, poi il corredo gelosamente custodito fino ad
allora nelle casse foderate di raso trapunto, poi i mobili, le pellicce,
i servizi di bicchieri e di piatti e antichi doni di nozze anch’essi
gelosamente custoditi, infine anche coperte e materassi di lana.  ngannammo
il tempo dell’attesa giocando a tombola con dei pezzetti di carta ( i
legumi erano una merce troppo preziosa) ma alle otto non resistevamo più
e ci trasferimmo di nuovo in cucina per riempirci gli occhi prima dello
stomaco delle croccanti pizze; c’era anche Bobby, il bastardino un po’
vecchiotto accucciato fra noi che stavamo in piedi, sperando che qualche
bocconcino cadesse anche per lui. Poverino! Anch’esso aveva sofferto la
fame nei primi tempi della guerra, poi si era fatto furbo e fra gli
accampamenti tedeschi prima e quelli alleati dopo non aveva certo
sentito i morsi della fame come noi. Comunque quella sera era là ad
aspettare e la sua attesa fu premiata perché un pezzetto di farina
fritta si era staccata dal resto e mia madre gli e la gettò.
ngannammo
il tempo dell’attesa giocando a tombola con dei pezzetti di carta ( i
legumi erano una merce troppo preziosa) ma alle otto non resistevamo più
e ci trasferimmo di nuovo in cucina per riempirci gli occhi prima dello
stomaco delle croccanti pizze; c’era anche Bobby, il bastardino un po’
vecchiotto accucciato fra noi che stavamo in piedi, sperando che qualche
bocconcino cadesse anche per lui. Poverino! Anch’esso aveva sofferto la
fame nei primi tempi della guerra, poi si era fatto furbo e fra gli
accampamenti tedeschi prima e quelli alleati dopo non aveva certo
sentito i morsi della fame come noi. Comunque quella sera era là ad
aspettare e la sua attesa fu premiata perché un pezzetto di farina
fritta si era staccata dal resto e mia madre gli e la gettò.